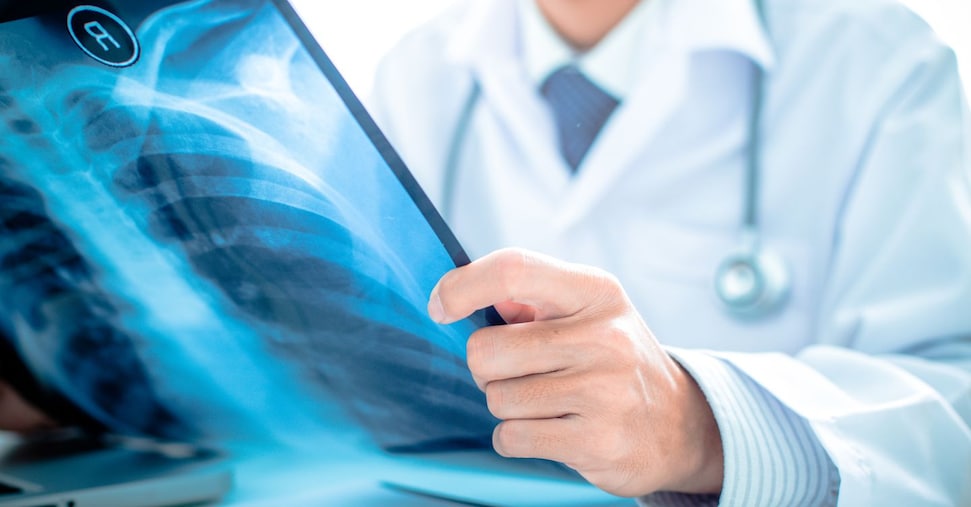Ho letto con interesse le parole del Governatore Fabio Panetta sul capitale umano e sul divario retributivo tra giovani laureati italiani e tedeschi. È vero: in Germania si guadagna di più. Ma, per quanto riguarda noi medici, questa verità va completata con un’altra, meno raccontata e molto più scomoda.
Negli ultimi anni la sanità tedesca è entrata in una fase di riforma e di contrazione strutturale: reparti accorpati, riduzione di posti letto, ospedali in difficoltà finanziaria e, in diversi casi, chiusure e licenziamenti. Il risultato non è solo un sistema più “efficiente”, ma spesso un sistema più fragile, dove il personale rimasto viene spremuto fino all’osso.
Nella pratica quotidiana, questo significa turni sempre più lunghi e pesanti, talvolta con guardie interdisciplinari di 24 ore in cui il medico di reparto diventa, contemporaneamente, ortopedico e traumatologo, ma anche neurochirurgo “di necessità”, chirurgo generale, toracico e viscerale. Non per scelta, né per formazione strutturata, ma perché l’organico non basta e la macchina deve continuare a funzionare comunque. È qui che il confronto salariale perde parte del suo senso: sì, lo stipendio è più alto, ma il carico di lavoro può essere il doppio o il triplo, con responsabilità cliniche e medico-legali che crescono in modo proporzionale — e spesso senza adeguato supporto.
A complicare il quadro c’è un dato che dovrebbe far riflettere: in Baviera, secondo statistiche ordinistiche regionali, i medici classificati come disoccupati sarebbero circa 3.000. È un numero che stona con la narrativa dominante della “carenza di medici” e suggerisce che qualcosa, nel meccanismo di reclutamento e allocazione del personale, non stia funzionando. Una carenza che convive con la disoccupazione non è un paradosso: è un segnale di attrito sistemico, di precarietà contrattuale, di transizioni forzate e di inefficienze amministrative che sottraggono capacità clinica proprio quando servirebbe di più.
Per l’Italia, tutto questo ha un significato preciso. Se vogliamo davvero “puntare sul capitale umano”, non basta inseguire il confronto dei salari. Serve rendere credibile un percorso professionale fatto di stabilità, crescita, merito e condizioni di lavoro sostenibili. Altrimenti continueremo a formare medici, ingegneri e informatici per poi perderli: non solo verso paesi che pagano meglio, ma verso sistemi che, pur pagandoli di più, li consumano più in fretta.